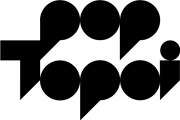Sono solo le 12 del primo giorno quando è chiaro che il Primavera Sound 2013 ha già un vincitore, almeno nella categoria indie-ironia al festival: il batterista degli argentini Go Neko! suona con una maglietta di American Idol. Il gruppo è il primo di una lunga serie a esibirsi nella terrazza dell’hotel Diagonal Zero per il pubblico del PrimaveraPro, evento parallelo per addetti ai lavori con conferenze sul settore. Da bravo secchione, faccio in tempo a vederne un paio. La migliore s’intitola “Welcome to the music industry: you’re fucked” ed è tenuta da Martin Atkins, musicista (PiL, NIN) diventato accademico non tanto grazie all’originalità dei suoi insegnamenti quanto per la sua bravura nel proporli in formato stand-up comedian. Tant’è vero che dimentico di stare ascoltando banalità sull’importanza dei social e i dischi paga-quanto-vuoi.
Sono solo le 12 del primo giorno quando è chiaro che il Primavera Sound 2013 ha già un vincitore, almeno nella categoria indie-ironia al festival: il batterista degli argentini Go Neko! suona con una maglietta di American Idol. Il gruppo è il primo di una lunga serie a esibirsi nella terrazza dell’hotel Diagonal Zero per il pubblico del PrimaveraPro, evento parallelo per addetti ai lavori con conferenze sul settore. Da bravo secchione, faccio in tempo a vederne un paio. La migliore s’intitola “Welcome to the music industry: you’re fucked” ed è tenuta da Martin Atkins, musicista (PiL, NIN) diventato accademico non tanto grazie all’originalità dei suoi insegnamenti quanto per la sua bravura nel proporli in formato stand-up comedian. Tant’è vero che dimentico di stare ascoltando banalità sull’importanza dei social e i dischi paga-quanto-vuoi.
Poco dopo, si va a dare un’occhiata alla delegazione italiana: Foxhound, Blue Willa, honeybird & the birdies. Questi ultimi, già visti al Primo maggio, sono quelli che ne escono meglio e con cui ci si diverte di più (non solo a causa dei costumi e la tropicalizzazione improvvisata del palco). 
 Bel colpo, per il Primavera Sound, aver puntato sulle Savages in tempi non sospetti. Fresche di un album nella top 20 britannica, le quattro ragazze arrivano alle 19.30 sul palco di Pitchfork (e dove, se no, dopo quell’8.7?) con grande sicurezza per poi piegarsi a metà set a causa di un problema tecnico che mette fuori uso la chitarra. Il pubblico, fino a quel momento non troppo partecipe, si scongela per incoraggiare le tre rimaste, che si arrangiano come possono sullo stesso giro di basso per più di dieci minuti. Un vero peccato, perché meritano davvero molto dal vivo.
Bel colpo, per il Primavera Sound, aver puntato sulle Savages in tempi non sospetti. Fresche di un album nella top 20 britannica, le quattro ragazze arrivano alle 19.30 sul palco di Pitchfork (e dove, se no, dopo quell’8.7?) con grande sicurezza per poi piegarsi a metà set a causa di un problema tecnico che mette fuori uso la chitarra. Il pubblico, fino a quel momento non troppo partecipe, si scongela per incoraggiare le tre rimaste, che si arrangiano come possono sullo stesso giro di basso per più di dieci minuti. Un vero peccato, perché meritano davvero molto dal vivo.
Dopo aver fatto finta che me ne fregasse davvero qualcosa dei Tame Impala oltre a quel carro armato di “Elephant”, mi rimetto a correre lasciandomi dietro il gruppo e i loro visual: “psichedelia anni 70” diranno loro, “salvaschermo Windows 95” dirò io. In realtà, sono molto in anticipo e riesco a posizionarmi in prima fila per Jessie Ware. Il grosso del pubblico arriverà a concerto iniziato e non se ne pentirà. Come avevo già avuto modo di scoprire l’anno scorso guardando qualche festival (in streaming), la Jessie Ware sul palco non ha molto in comune con la Jessie Ware su disco. In Devotion (e nei video di Kate Moross che lo promuovono), la cantautrice è una diva altezzosa, irraggiungibile, che canta in modo controllato e delicato; dal vivo, è calorosa, coinvolgente e dà gran sfoggio della sua potenza vocale. La raffinatezza del disco è stravolta e l’assetto della band che l’accompagna (un tradizionale basso-chitarra-batteria) contribuisce ad adattare i brani al contesto del festival. E la diva al tempo della crisi, forse non potendosi permettere coriste, usa cori registrati che attiva lei stessa dal sequencer. Si diverte, scherza (prima di “110%/If You’re Never Gonna Move” e “Imagine It Was Us”,  avverte: “ballate ora perché sono i due unici pezzi movimentati del mio repertorio”) e il pubblico, che la vede arrivare per la prima volta in Spagna, la accoglie cantando i testi a memoria con le dita puntate al cielo. Valeva la pena volare fino a Barcellona anche solo per lei.
avverte: “ballate ora perché sono i due unici pezzi movimentati del mio repertorio”) e il pubblico, che la vede arrivare per la prima volta in Spagna, la accoglie cantando i testi a memoria con le dita puntate al cielo. Valeva la pena volare fino a Barcellona anche solo per lei.

Di nuovo Heineken stage per i Postal Service. Se Gibbard e Tamborello non si fossero fermati a un album nel 2003, sarebbero tra gli headliner a un festival nel 2013? Si potrebbe fare un paragone con Arrested Development, serie TV iniziata negli stessi anni che lunedì tornerà con nuovi episodi dopo aver raggiunto lo status di cult anche a causa della sua cancellazione. Ma a differenza di Arrested Development, Give Up non è invecchiato granché bene: come accoglieremmo oggi un album con testi tanto naïf sul surriscaldamento globale e il perfetto allineamento delle lentiggini di due amanti mentre si baciano? Eppure, anche incolpando la dilagante nostalgia, i Postal Service con Jenny Lewis  dal vivo ti stampano un sorriso idiota in faccia. Anche il nuovo materiale (la mediocre “Tattered Line of String”) e i brani meno memorabili come “Recycled Air” sono eseguiti e accolti con emozione e trasporto. Per “Such Great Heights”, invece, consultare la voce “incontenibile gioia del trentenne occidentale medio”.
dal vivo ti stampano un sorriso idiota in faccia. Anche il nuovo materiale (la mediocre “Tattered Line of String”) e i brani meno memorabili come “Recycled Air” sono eseguiti e accolti con emozione e trasporto. Per “Such Great Heights”, invece, consultare la voce “incontenibile gioia del trentenne occidentale medio”.
 I Phoenix sono un gruppo di cui non ho avevo mai capito l’appeal. E a chi mi diceva “devi vederli dal vivo!”, rispondevo che li avevo già visti: suonarono a un festival italiano dopo (o forse addirittura prima) dei Baustelle dello yé-yé. Però, sono passati quasi dieci anni e ora i Phoenix hanno canzoni che possono buttare giù le arene (la migliore del nuovo disco, “The Real Thing”, sembra avere proprio questo scopo) e le eseguono con una precisione impressionante. Non c’è una sbavatura, è un concerto pop grosso di un gruppo all’apice della fama che può fregarsene del minimalismo e dell’umiltà (però, seriamente, il visual con la cartolina di Versailles potevano evitarselo). Ora, se non avessi a cuore il mestiere degli addetti alla sicurezza, mi sarei messo a urlare “ZOMG LOOK DAFT PUNK ARE HERE”. Ma non voglio causare stampede. I robot non si presentano (e perché mai dovrebbero, poi) e dopo dieci minuti di Four Tet dal lato opposto del parco, mi arrendo. Sono le 3 del mattino.
I Phoenix sono un gruppo di cui non ho avevo mai capito l’appeal. E a chi mi diceva “devi vederli dal vivo!”, rispondevo che li avevo già visti: suonarono a un festival italiano dopo (o forse addirittura prima) dei Baustelle dello yé-yé. Però, sono passati quasi dieci anni e ora i Phoenix hanno canzoni che possono buttare giù le arene (la migliore del nuovo disco, “The Real Thing”, sembra avere proprio questo scopo) e le eseguono con una precisione impressionante. Non c’è una sbavatura, è un concerto pop grosso di un gruppo all’apice della fama che può fregarsene del minimalismo e dell’umiltà (però, seriamente, il visual con la cartolina di Versailles potevano evitarselo). Ora, se non avessi a cuore il mestiere degli addetti alla sicurezza, mi sarei messo a urlare “ZOMG LOOK DAFT PUNK ARE HERE”. Ma non voglio causare stampede. I robot non si presentano (e perché mai dovrebbero, poi) e dopo dieci minuti di Four Tet dal lato opposto del parco, mi arrendo. Sono le 3 del mattino.
Pop Topoi
Un blog che, per l'appunto, parla di musica pop