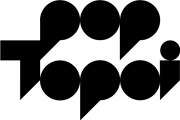L’anno scorso, alla chiusura del festival, scrivevo: “dopo i Radiohead non si torna più indietro”. A parlare era un po’ la delusione per non essere riuscito a godermi il loro set a causa di un pubblico distratto, rumoroso e maleducato – il pubblico generico di un grande festival mainstream, insomma. Che non si torni più indietro è tuttora vero (e l’iper-brandizzizazione di ogni angolo del Parc e i dieci minuti di pubblicità sui megaschermi prima dei concerti sono lì a ricordarcelo), ma ieri sera si respirava l’atmosfera di qualche anno fa, almeno sotto il palco dei tre artisti che ho seguito con maggiore attenzione. Davanti a Miguel e Solange si percepiva l’eccitazione di vedere artisti che raramente si esibiscono nell’Europa continentale; davanti a Bon Iver c’era un pubblico emozionato e non una folla di curiosi.

Miguel, a sorpresa, sarà forse il concerto più rock che vedrò in questa edizione. Coi suoi backdrop psichedelici, gli assoli di chitarra e una band ridotta a tre elementi (e tutti in camicie hawaiane), il livello di testosterone è a livelli di guardia. Lui è consapevole della sua carica erotica e flirta spudoratamente cantando di sesso e droghe e sesso attraverso le droghe. Il paragone ovvio è The Weeknd, ma per Miguel si tratta solo di divertirsi: l’alienazione e lo squallore di Tesfaye (che lui spesso confonde con trasgressione) sono lontani. Ed è lontano anche il Miguel pop/R&B delle collaborazioni con Mariah Carey, Janelle Monáe e Dua Lipa: questo è un concerto rock, e ben riuscito.

Si passa al palco Mango, dove un telo bianco con un cerchio sospeso lasciano intendere che il set di Solange avrà un alto potenziale concettuale. E sì, si rivelerà uno spettacolo interamente coreografato e calcolatissimo, ma per fortuna è anche leggero e godibile. Innanzitutto i colori: le nove persone sul palco sono tutte vestite di rosso, così come le luci proiettate sullo sfondo. Questo rende il tutto non fotografabile e forse non è un caso. Nel 2013, quando cantò sul palco Pitchfork davanti a pochi lungimiranti eletti (ciao!), ricordo che Solange chiese, durante “Losing You”, di mettere via i telefoni e godersi il momento: che ora abbia trovato una soluzione più elegante per concentrare la nostra attenzione su di lei anziché sui nostri touchscreen? Di cose ne sono cambiate da quello slot pomeridiano al Primavera di quattro anni fa: ha litigato col musicista che l’aiutò a trovare nuovi suoni (Dev Hynes), buttando forse ore di musica che non sentiremo mai; è diventata suo malgrado famosa per avere picchiato il marito di sua sorella in un ascensore; ha avuto un album al primo posto della Billboard. Sembra avere fatto pace con gli insuccessi della sua prima carriera, tant’è che ne ripropone qualcuno dal vivo e si dilunga in ringraziamenti per i collaboratori che la seguono fin dall’inizio. Lei viene presentata come “creator” dello spettacolo e si assiste davvero alla creazione di un’artista al suo picco creativo, che vuole trasmettere serenità (e riesce a farlo dispensando pillole di saggezza senza banalità, come in “Cranes in the Sky”) e calore (si butta nel pubblico durante l’inno di empowerment “F.U.B.U”, accolta con più sorrisi complici che reazioni scomposte). Resterei fino alla fine, proprio per risentire quella “Losing You” che mi conquistò quattro anni fa, ma è tempo di spostarsi per l’headliner della serata.

A Seat at the Table battè 22, A Million l’ottobre scorso, ma è un album altrettanto importante. Bon Iver lo suona per intero, circondato dai misteriosi simboli della sua copertina. Non era facile tradurre dal vivo un’opera così intima, col suo collage di campionamenti e distorsioni, ma la resa è notevole. Vernon rende l’auto-tune umano nel brano a cappella “715 – CR∑∑KS” e il frammento di Mahalia Jackson in “22 (OVER S∞∞N)” ha tutta l’intensità della versione studio. Si sposta poi in quelle che chiama “country jam”, continuando a commuovere, fino al finale solitario di “Skinny Love”. La regia dei megaschermi non esita a proiettare immagini di maschi bianchi etero che piangono nel pubblico, e che vengono salutati da applausi spontanei. È un concerto purissimo, accolto col trasporto e il rispetto che merita, e che va a completare un trio perfetto di artisti statunitensi visti oggi. Miguel, di origini messicane e africane, che parla di amore universale tra una canzone e l’altra; Solange, che scrive un nuovo capitolo nella musica nera con un album e uno spettacolo serenamente politici; Bon Iver, che invita i presenti a informarsi sulla sua campagna (2 A Billion) per porre fine alla disuguaglianza di genere. Se non fosse così tardi, direi di avere assistito a tre espressioni della resistenza anti-Trump.