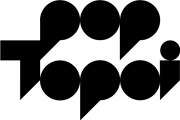L’ultimo giorno di Primavera inizia con la conferenza stampa conclusiva e gli organizzatori confermano la sensazione generale: il festival è ancora un successo ed è in crescita costante. 200.000 accessi durante la settimana (eventi paralleli in città inclusi), e il tutto esaurito anche per la sezione PrimaveraPro per i professionisti dell’industria musicale. Quest’anno, grazie ai (o per colpa dei) Radiohead, non si torna più indietro: il Primavera Sound è un festival a tutti gli effetti mainstream che viaggia verso la perfezione (la scelta di artisti è ampia ma non impossibile da gestire; non c’è il fango e non è in un deserto; quest’anno si mangiava pure bene). E a proposito di Radiohead, un giornalista chiede la ragione dei volumi così bassi durante il loro concerto e gli organizzatori rispondono che i tecnici della band hanno agito in totale libertà.
Il primo live del giorno è il più quando-ti-ricapita ma anche il più WTF del festival. La norvegese JENNY HVAL sembra la somma dei The Knife, Maddie Ziegler nei video di Sia e i Monologhi della vagina. Più che un concerto, è una pièce di performance art femminista in cui Jenny fa riflessioni politiche e sociali intervallate da canzoni elettroniche astratte, ma eseguite con un grande talento vocale. Proprio come i The Knife, non si sa bene dove sia il confine tra ironia e serietà, e nel dubbio l’abbandono per recarmi dalla regina indiscussa di questa edizione.
PJ HARVEY sale sul palco suonando il sassofono (Carly Rae Jepsen’s impact) e accompagnata da una band, o meglio, una banda di otto elementi, tra cui l’italiano Enrico Gabrielli. La prima parte della scaletta è interamente dedicata a brani tratti dagli ultimi due album – quelli, per così dire, documentaristici. The Hope Six Demolition Project qualche mese fa aveva sollevato perplessità sui suoi metodi di ricerca e l’accusa di poverty tourism sembrava fondata. Eppure, per quanto possa sembrare sciocco, vedere quei brani interpretati dal vivo mi fa davvero credere che le intenzioni siano sincere e il backlash esagerato. Nei brani in questione, PJ è trasparente, appassionata e diretta, e la resa live è di gran lunga superiore a quella in studio. Sono pressoché marce militari che fanno battere mani e piedi a tempo, e la direttrice d’orchestra trova subito una sintonia col pubblico rara. Mi trovo addirittura a non rimpiangere affatto i vecchi lavori e a rivalutare la discografia recente (un’enorme “The Ministry of Defence” è l’esempio più eclatante, ma anche l’asettica “When Under Ether” trova una nuova veste di grande impatto). Decido che è il mio concerto preferito del Primavera 2016 ancora prima che esegua pezzi degli anni ’90 – e quando questi arrivano, com’era prevedibile, non ce n’è più per nessuno. Ne bastano tre: “50 ft Queenie”, “Down By the Water”, “To Bring You My Love”. Qualcuno urla “YASS QUEEN”. Ci sta.
Gli altri headliner, subito dopo, sono i SIGUR RÓS, che hanno alle spalle quasi vent’anni di carriera di cui dieci senza un’idea nuova o rilevante, ma dal vivo restano una macchina da guerra. Si ripete l’esperienza dei Radiohead: troppi passanti e troppi ascoltatori casuali in vena di chiacchiere e goliardia rovinano l’ascolto (che non deve essere un rituale religioso, per carità, ma cosa avranno mai da raccontarsi tutte ‘ste persone durante quel pugnale di “Vaka”?) Più forti di me nello zittire i chiacchieroni, solo quelli che si sono fatti una canna apposta per ascoltare Jónsi e non se la stanno godendo. La scaletta accontenta anche i nostalgici, ma in due ore non ci si può aspettare di sentire tutti i brani preferiti visto che hanno una durata media di 8 minuti (abbiamo avuto “Glósóli” e “Starálfur”, ma non abbiamo fatto “tjuuuú” su “Svefn-g-englar” né saltato nelle pozzanghere con “Hoppipolla”).
Si ritorna all’Heineken stage per i MODERAT, che per me si rivelano una grande sorpresa dal vivo. La loro caratteristica migliore è la varietà: passano da momenti ambient all’house più ballabile, al quasi-pop di brani come “Bad Kingdom” che il pubblico canta a memoria. Il trio tedesco è nella posizione invidiabile di chi continua a rinnovarsi guadagnando nuovi ascoltatori a ogni passo ma senza mai perdere credibilità, e Apparat, chi l’avrebbe mai detto, sembra proprio a suo agio nel ruolo di frontman e cantante. A completare un set senza difetti, luci e visual tra i migliori visti di recente. Da un lato, è la chiusura perfetta di un festival che si è aperto a nuovi generi mantenendo la propria identità (i Moderat come metafora del Primavera Sound: l’ho fatto); dall’altro, si vorrebbero avere più energie residue per goderne appieno.
Sto infatti per abbandonare quando saluto altri primaveristi ballanti al Pitchfork stage con ROOSEVELT e poi, perché tanto sono solo le quattro, li seguo al palco accanto per ISLAM CHIPSY & EEK. Avrei dovuto chiudere il report coi Moderat come metafora del Primavera Sound perché, per la musica egiziana contaminata dall’elettronica che ho sentito dopo, mi mancano le figure retoriche.
Foto PJ Harvey: Eric Pamies; foto Sigur Rós: Marc Heimendinger