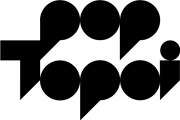È l’ultimo giorno di festival ed è anche quello col programma più impegnativo perché pieno di sovrapposizioni. Si comincia presto, alle 19, con Teho Teardo e Blixa Bargeld all’Auditori Rockdeluxe: un posto al chiuso, con le sedie, asciutto, civilizzato e senza odore di churros. Il compositore italiano (unico connazionale in cartellone escludendo quelli promossi da Sfera Cubica) e il cantante/attore tedesco portano qui la loro strana collaborazione, aiutati dapprima solo da un violoncello e poi, nella seconda metà, da un giovane ottetto d’archi locale. Ma a rubare la scena (e ad animare un concerto bello ma potenzialmente noioso) è la piccolissima figlia di Bargeld, che invade il palco, abbraccia la gamba del padre, si siede ai suoi piedi e non vuole più andarsene – il tutto con un tempismo così perfetto da far sospettare fosse una scena studiata (non lo era: la madre al lato del palco non sapeva più come trascinarla giù). Teardo e Bargeld eseguono gran parte di Still Smiling e gli highlight sono l’incredibile “Mi scusi” (quella in cui “le gambe mi fanno giacomo giacomo giacomo”) e “Come Up and See Me” (quella in cui elencano tutti i canali della tv italiana da Raiuno a TGcom). Sul finale, trovano il tempo per una cover di Caetano Veloso, una maledizione che mi perseguiterà anche fuori dall’Auditori dove vado a raggiungere altri primaveristi. L’artista brasiliano, dopo anni di corteggiamenti da parte dell’organizzazione, si esibisce finalmente al festival in un’apoteosi di fabiofazismo spinto. È troppo: mi sposto al palco Pitchfork per vedere l’effetto che fa Earl Sweatshirt.

…e non mi fa un grande effetto. È un personaggio affascinante e con una storia incredibile, ma se non si ha la pazienza di entrare nella sua narrazione, si trova solo un rapper virtuoso con basi pesanti e rime misogine.

Kendrick Lamar rappresenta l’apertura maggiore al mainstream americano del festival (e forse non era così mainstream quando gli è stato chiesto di parteciparvi) (di certo non aveva ancora collaborato con gli Imagine Dragons ai Grammy, ecco). Il suo successo è però meritatissimo e ce ne accorgiamo dopo pochi secondi e soprattutto nella parte centrale di “Swimming Pools”, quando cambia registro e si trasforma nella voce della sua coscienza. L’artista mi fa inoltre un grandissimo favore: comprimere all’inizio del set la già citata “Swimming Pools”, “Bitch Don’t Kill My Vibe” e “Backseat Freestyle” così posso poi trasferirmi sereno verso altri palchi.
Al palco Pitchfork ritrovo tutti gli amici dispersi a causa di un’assenza di rete che mette tutti in difficoltà, e ci ritrovo anche Dev Hynes. L’artista torna sul luogo delitto: è proprio qui che suonò con Solange nel 2013. Nell’ultimo anno gli è successo di tutto: gli è andata a fuoco la casa, gli è morto il cane e ha litigato con la Knowles minore (compromettendo un album insieme che forse non vedrà mai la luce). La mancanza di Solange si sente tutta e viene compensata con una sosia e la fidanzata Samantha Urbani, più cotonata che intonata. Il concerto alterna canzoni indistinguibili l’una dall’altra e cose ballabilissime a patto che non si voglia competere con chi le sta ballando sul palco. Ma non mi diverto come vorrei perché ho troppa ansia di correre verso l’altra parte del Parc per capire se i Nine Inch Nails, nell’anno del Signore 2014, hanno un senso.
Sono passati 14 (quattordici) anni dall’ultima volta che ho visto i NIN. Era mezza vita fa, era il mio primo festival ed era durante il tour di The Fragile, il loro capolavoro indiscusso nonché un picco che ha reso inutili le loro fatiche successive. Ma, negli anni, Reznor ha anche aggiunto al curriculum altri progetti paralleli (How to destroy angels_ e ovviamente le colonne sonore di Fincher), ravvivando non solo il suo status (più percepito che reale) di pioniere, ma anche quello della band. Se sono al Primavera, vuol dire che i NIN sono ancora vivi – e vantano la fanbase più nutrita del festival, a giudicare dalle magliette del pubblico. La scaletta esce qualche ora prima ed è un sollievo perché ci si può regolare e farsi vivi verso la metà, su “Closer”. Ma “Closer” non arriva nel punto previsto perché la scaletta è sbagliata. PIÙ CLOSER E MENO FILLER, per cortesia. Trent fa infatti un concerto per fan accaniti, recuperando album tracks, singoli che non hanno venduto e pezzi che suonano simili ma inferiori a quelli storici. Sapevo non sarebbe stato un concerto di 100% grandi successi perché si chiamano NIN e non RDS, ma questo è troppo. Lo spettacolo è tecnicamente impeccabile e il palco Sony si conferma l’eccellenza, ma un concerto in cui “Hand That Feeds” è un highlight, non è un concerto da ricordare.
Se non avessi lasciato le ultime energie che avevo su “Head Like a Hole”, il concerto dei Chromeo entrerebbe nella mia top 5. I due sono una macchina da guerra: sono catchy, sono kitsch, sono il modo migliore per chiudere (volendo fare finta che i Cut Copy non esistano perché esistono alle 4 di mattina). Ma l’evento finisce davvero solo quando si appoggia il culo sui sedili della metro (sì, ancora aperta e funzionante a quell’ora) e si finisce a fare il totoPrimavera 2015. Questo è l’effetto che ci fa il festival e che ti fa venire voglia di dare ragione a Bradford Cox.