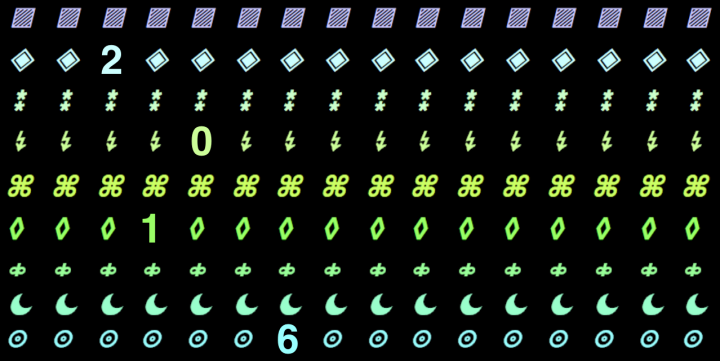C’è una brughiera ventosa al tramonto e una donna seduta di spalle che suona il flauto. Lentamente l’inquadratura si apre e rivela un paesaggio extraterrestre eppure rassicurante. La donna suona, o forse incanta, sgorbi alieni sospesi a mezz’aria, mentre sullo sfondo si intravvede una caverna dall’entrata vulviforme. Benvenuti a Utopia. Abitanti: una, ma il suo sguardo è accogliente e gli inviti sono aperti.
Il video di “The Gate”, uscito a settembre, ci preparava così all’inizio di un nuovo capitolo nella discografia di Björk. Come suggeriscono le prime parole del testo, la ferita sul petto che esibiva sulla copertina del precedente Vulnicura (e che rappresentava la fine del suo matrimonio), è guarita e si è trasformata in un portale per ricevere di nuovo amore. Nel video, infatti, l’artista accoglie e rilancia sfere di luce, celebrando la libertà ritrovata. L’ha chiamato il suo “Tinder record” – una definizione che è piaciuta molto ai media, e che ai media è piaciuto travisare – e lo è davvero. Non perché Björk usi un’app per incontri, ma perché alcuni brani diUtopia descrivono la sensazione di riaprirsi al mondo dopo una rottura, di ritrovare la fiducia in nuove persone e immaginare l’innamoramento. Questo, oggi, avviene inevitabilmente online, e l’artista, che ha da sempre un rapporto positivo con la tecnologia, vuole sottolinearlo. In “Blissing Me” è intenta a scambiarsi mp3 con un altro “music nerd” e non sa se si è innamorata di una canzone o del suo mittente (sembra quasi l’aggiornamento di “Headphones” del ’95, ode alle mixtape create per lei dal produttore Graham Massey). In “Features Creatures” diventa una dottoressa Frankenstein che assembla l’uomo ideale attraverso caratteristiche da profilo online; in “Arisen My Senses”, che apre l’album, è alla ricerca di una connessione, calore e sesso.
Björk voleva leggerezza e l’ha trovata nei fiati e nei campionamenti di uccelli islandesi e venezuelani che decorano le tracce. Dopo l’esperienza di Vulnicura, in cui la sua voce entrava in competizione con archi maestosi e sprofondava nel dolore dell’amore finito, vuole offrire speranza e portarci coi suoni in foreste ancestrali mentre le parole descrivono, con un linguaggio più contemporaneo di quello di molte popstar adolescenti, le interazioni al tempo dell’iPhone.
È una leggerezza relativa: è l’album più lungo della sua discografia, contiene un brano/tour de force di dieci minuti e quasi tutti gli altri potevano essere accorciati. E anche la collaborazione con Arca, col quale ha instaurato un’intensa amicizia lavorando sul disco precedente, porta con sé dei rischi. Da una parte, il musicista venezuelano sa creare un perfetto equilibrio tra nuove idee e citazioni del catalogo björkiano: i due trovano soluzioni incredibili e aliene, suoni che abbagliano, momenti di pura gioia che potevano nascere solo da un approccio giocoso e divertito come il loro. Ma dall’altra, Arca non è un produttore nel senso più tradizionale del termine, ovvero uno che in alcuni casi suggerirebbe modifiche per dare più coesione all’opera, che risulta prolissa e fatica a seguire il suo stesso concept. L’utopia, infatti, nella parte centrale del disco, è guastata da alcuni aspetti della nostra realtà che s’insinuano nei brani: in “Courtship” Björk assaggia “il siero paralizzante del rifiuto”; in “Sue Me” e “Tabula Rasa”, torna a parlare di divorzio. Tuttavia, se in Vulnicura la ferita era troppo fresca per ragionare, qui l’artista affronta le questioni legali e sentimentali con maggiore compostezza. Non vuole più fare la guerra all’ex perché ha ancora ricordi teneri della loro relazione, e perché vuole proteggere la figlia dagli errori dei genitori.
Nulla può l’escapismo sonoro contro i casini che si combinano per amore, contro il passato che inquina il presente e rimanda la fuga verso Utopia. Ma Utopia non è un luogo a sé: è un suggerimento, è l’idea di un futuro (“Future Forever”) che rende questa realtà sopportabile.
da Rockol
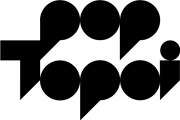

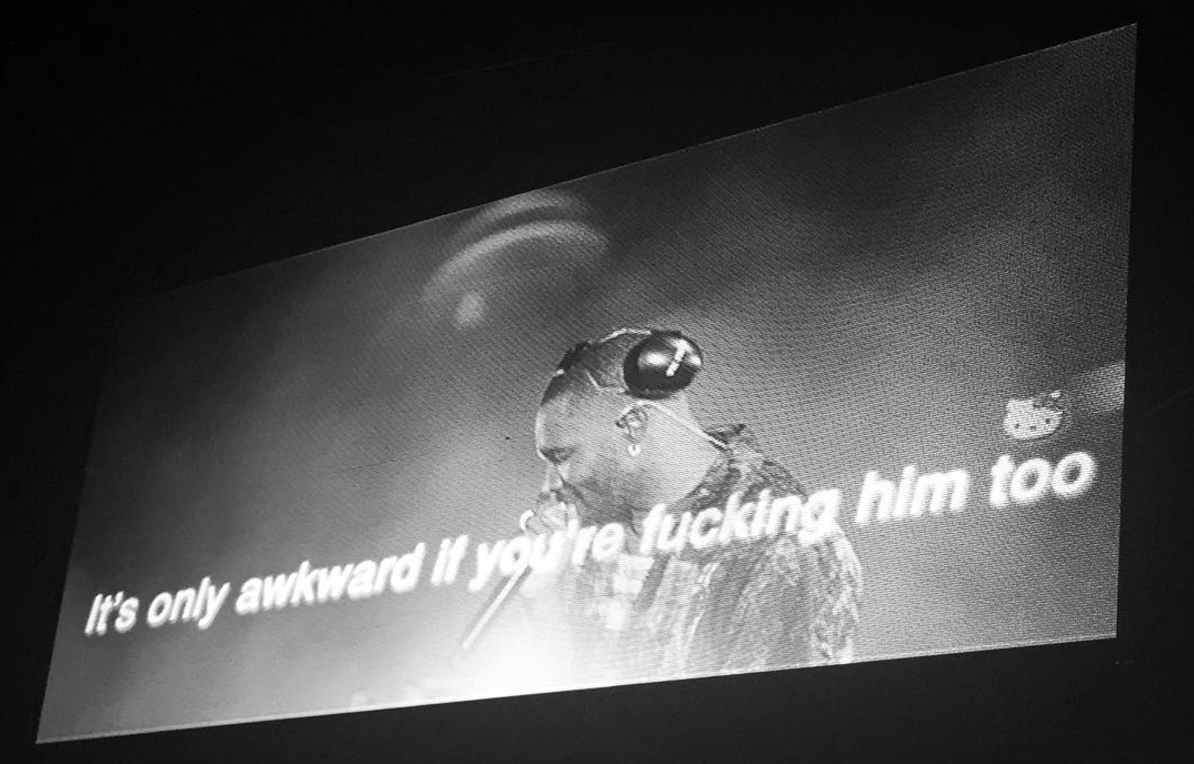
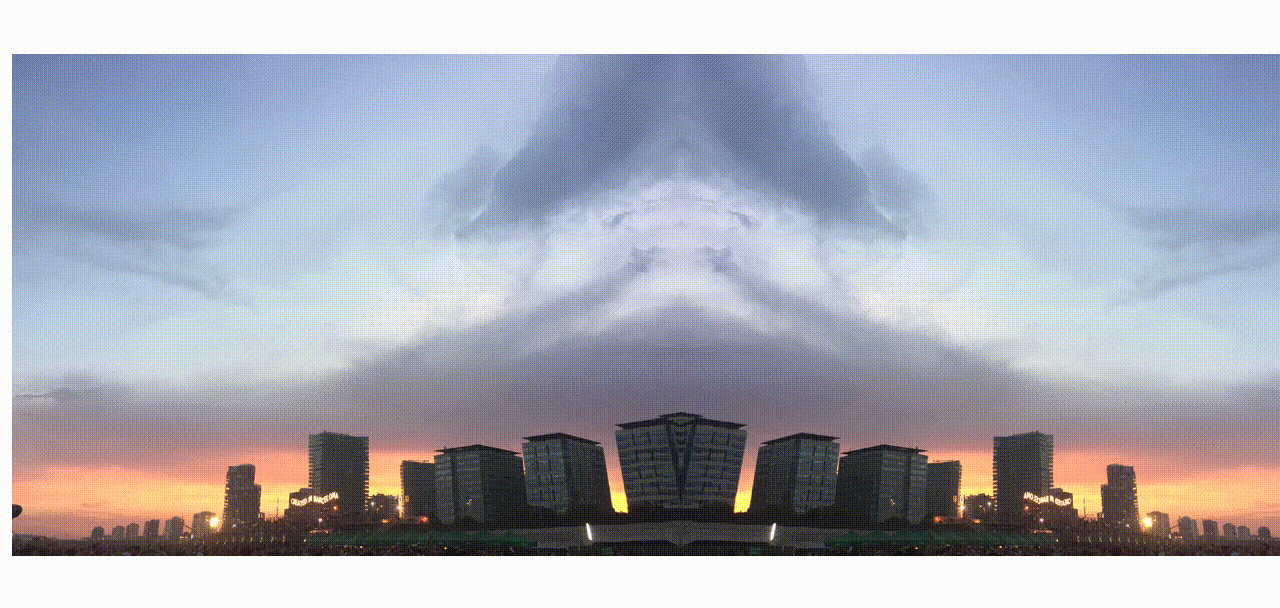
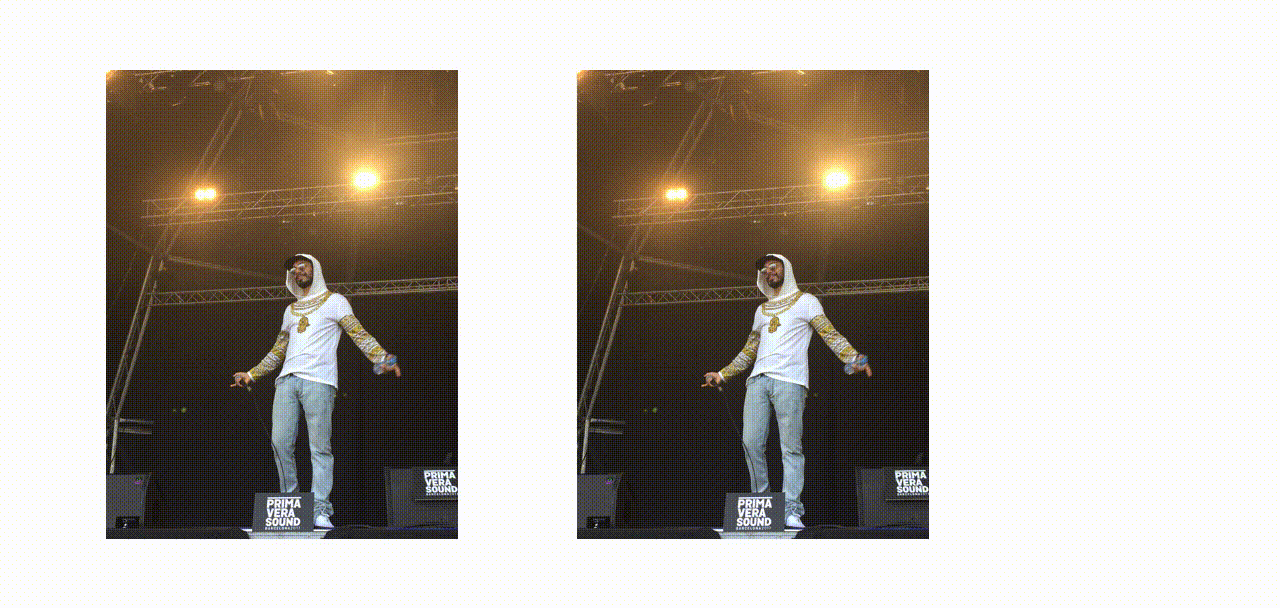
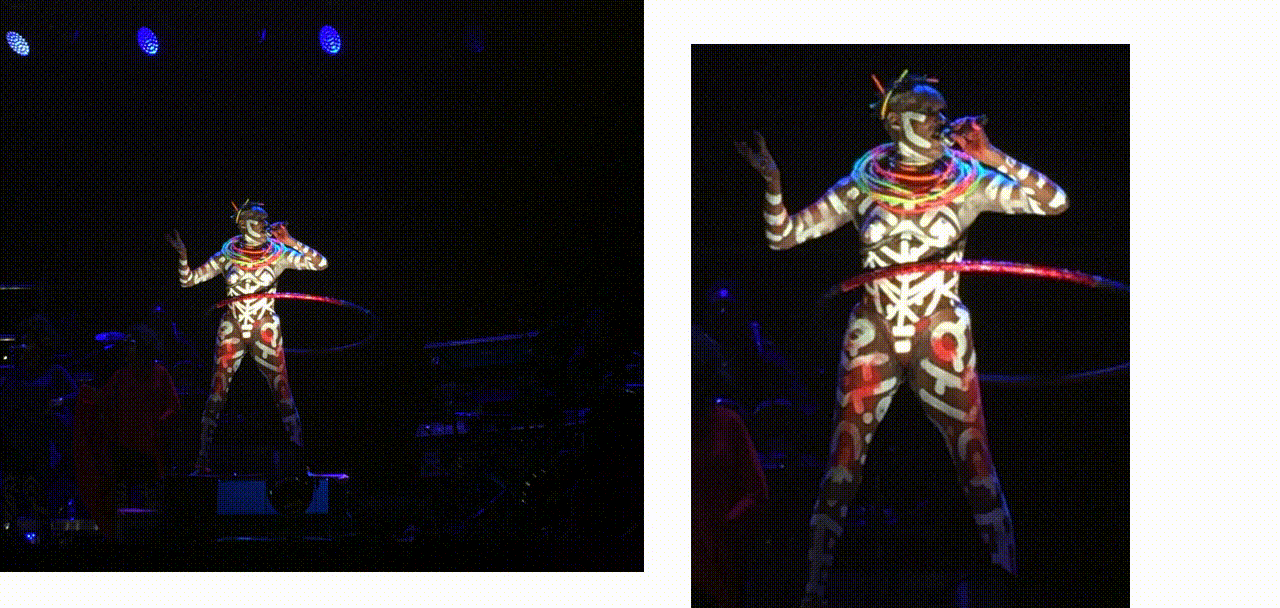
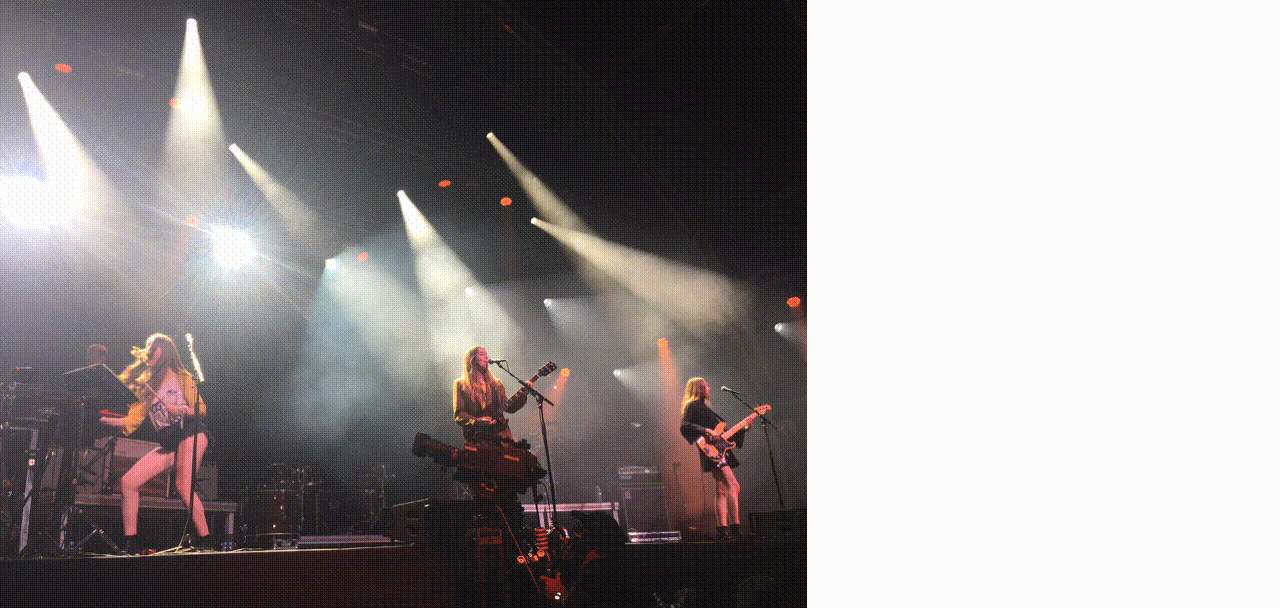









 Riepilogando:
Riepilogando: L’estate scorsa è stata pubblicata una raccolta di Cristina D’Avena, maldestramente intitolata #le sigle più belle. Quell’hashtag, di fatto, è poco utile su Twitter, perché la funzione di ricerca, così limitata a “#le”, non porta alcun risultato pertinente al disco e non facilita la promozione. Ma sorvoliamo perché, titolo nonostante, si tratta di un capitolo molto importante nella carriera della cantante. #le sigle più belle è infatti il primo album di Cristina D’Avena a raggiungere la top 3 italiana. E questa è la storia di come sono arrivato a scrivere la frase precedente.
L’estate scorsa è stata pubblicata una raccolta di Cristina D’Avena, maldestramente intitolata #le sigle più belle. Quell’hashtag, di fatto, è poco utile su Twitter, perché la funzione di ricerca, così limitata a “#le”, non porta alcun risultato pertinente al disco e non facilita la promozione. Ma sorvoliamo perché, titolo nonostante, si tratta di un capitolo molto importante nella carriera della cantante. #le sigle più belle è infatti il primo album di Cristina D’Avena a raggiungere la top 3 italiana. E questa è la storia di come sono arrivato a scrivere la frase precedente.