
Nel 1985, Kate Bush ricevette in dono da suo fratello Paddy un giubbotto di salvataggio. La cantante aveva appena pubblicato Hounds of Love, che conteneva, nella seconda parte, una suite su una donna caduta in mare che aspetta i soccorsi (“The Ninth Wave”). Quasi trent’anni dopo, Kate Bush è a mollo in una vasca in uno studio londinese per registrare i visual del secondo spettacolo dal vivo della sua carriera. Sebbene le serva solo un filmato di pochi minuti, le riprese durano sei ore e, verso la fine, inizia a mostrare segni di ipotermia. Inquadrata dall’alto, pallidissima, canta di naufragi. E indossa quel giubbotto.
Kate Bush dice che quel giorno ha iniziato a dubitare della sua salute mentale – e non solo perché, a 56 anni, si è fatta immergere in una vasca gelida in nome dell’arte: quel giorno deve anche avere messo in discussione il ritorno alle scene, per giunta dal vivo. Non ha un bel ricordo del suo primo e, fino a un mese fa, unico tour. Durante The Tour of Life, aveva vent’anni, era la cantante più controversa d’Inghilterra e, purtroppo per lei, la sua filosofia non era haters gonna hate. Inoltre, la sua creatività andava a scontrarsi continuamente con le tendenze del tempo, con le limitazioni delle tecnologia e coi costi di produzione. L’esperienza divenne da spiacevole a insopportabile dopo la morte di un tecnico, e decise di non ripeterla.
Eppure, 35 anni dopo, Kate Bush torna nello stesso teatro dove chiuse il capitolo della musica dal vivo, e lo riapre in modo grandioso. Lo fa per dare vita a due suite (“The Ninth Wave”, appunto, da Hounds of Love, e “A Sky of Honey” da Aerial del 2004), ma è abbastanza generosa da accettare un compromesso. Pur non suonando nulla dai primi quattro album, concede una manciata di successi all’inizio dello spettacolo: “Hounds of Love”, “Running Up That Hill” e una “King of the Mountain” che è pronta per essere rivalutata come classico. A costo di trasformarsi in tribute band di se stessa, Kate Bush non stravolge le versioni originali: dopotutto, escludendo qualche rara performance televisiva, quei brani non erano mai stati eseguiti dal vivo. La voce, sì, è cambiata, ma libera dalle esagerazioni di un tempo (o dalle forzature imposte dal personaggio), riesce a mettere in maggiore risalto i monoliti della sua discografia. Anche visivamente ci sono poche distrazioni, e la prima mezz’ora di show, con la cantante vestita sobriamente di nero e scalza, è la cosa più rock ‘n roll della sua carriera. Ma, una volta accomodate le esigenze del pubblico, può concentrarsi sulla vera ragione del suo ritorno. La coda di “King of the Mountain” viene interrotta bruscamente da rumori di tempesta, la band indietreggia e sul megaschermo appare il video di un uomo che, attraverso un cannocchiale, vede una nave affondare e chiama la guardia costiera. Quest’introduzione a “The Ninth Wave” serve a chiarificare la storia narrata nella suite e che, fino a oggi, non aveva potuto usufruire di aiuti visivi. Col senno di poi, il musical teatrale era il mezzo più ovvio per proporla.
Kate Bush è una naufraga nella notte e l’unica cosa che vede è la lucina di emergenza del suo giubbotto. Le allucinazioni la portano a pensare di essere intrappolata sotto il ghiaccio (“Under the Ice”) e risvegliano paure ancestrali (“Waking the Witch”). La scena si trasferisce poi in un salotto simpsoniano, dove figlio e marito guardano la tv ignari (“Watching You Without Me”). Lei cerca di comunicare con loro, ma è un fantasma senza voce, un poltergeist che può solo interferire con l’elettricità. Fa poi un salto avanti nel tempo, dove l’anziana versione di se stessa implora che la giovane del presente continui a vivere perché il futuro si realizzi. Quando arrivano i soccorsi all’alba (“The Morning Fog”), sembra di avere assistito all’intera gamma di spettacoli del West End, ma con canzoni migliori, meno jazz hands e più comparse vestite da lische di pesce.
La seconda parte dello spettacolo, “A Sky of Honey”, è la descrizione di una perfetta giornata estiva e non ha quindi la stessa ricchezza narrativa. Il concept rende la produzione più libera di perdersi in visioni astratte e perlopiù ornamentali: c’è la storia di un burattino che diventa umano e un pittore che si lamenta perché la pioggia sta facendo colare la pittura del suo quadro. L’idillico “A Sky of Honey” non è travolgente quanto “The Ninth Wave”, ma sorprende con un inaspettato cambio di registro sul finale: in un crescendo epico e tetro, vengono calati due tronchi dal soffitto, l’intera band si trasforma in uno stormo di uccelli indossando maschere inquietanti e Kate Bush spalanca un enorme portone volando con ali di corvo.
Per quanto il concerto risulti senza dubbio spettacolare grazie a queste trovate, non sembra di assistere a una creazione contemporanea. Se, dal punto di vista della tecnologia, The Tour of Life del ’79 era lo stato dell’arte (pare che il primo microfono headset sia stato proprio inventato per Bush, che aveva bisogno di tenere le mani libere per ballare), Before the Dawn è relativamente low-tech. I burattini di legno, i lenzuoli fluttuanti per rappresentare il mare, un braccio meccanico calato dal soffitto con una macchina del fumo e un faro per imitare un elicottero… In alcuni punti, sembra una produzione scolastica che ha perso il controllo dopo la scoperta dell’LSD o una produzione professionale che avrebbe bisogno di un budget e un palco tre volte più grandi. Ma anche quest’aspetto artigianale ha il suo fascino: lo rende uno spettacolo buffo, camp, inglese. Ci si sorprende per Bush che scompare e riappare da una botola al lato opposto del palco o per cannoni che sparano bigliettini con una poesia: piccole cose, se paragonate agli effetti speciali e le acrobazie delle grandi popstar nelle arene, ma non si può avere uno spettacolo pirotecnico e intimo allo stesso tempo. E all’Apollo di Hammersmith, tutti possono vedere le espressioni facciali di chi canta senza l’uso di megaschermi (e senza la distrazione, cordialmente vietata, dei cellulari).
È un’artista che sembra improvvisamente felice di accoglierci nel suo mondo, e il suo mondo, oggi, ruota attorno al figlio adolescente Albert “Bertie” McIntosh. È il responsabile sia dell’assenza prolungata che del ritorno inaspettato della madre (pare proprio sia stato lui a convincerla), e poiché nemmeno i genitori più illuminati sanno dire no ai figli con velleità artistiche, Bertie ha molto spazio nello spettacolo. Interpreta “se stesso” nella prima suite e il pittore nella seconda, con una lunga parte cantata (l’unico inedito della setlist) in cui l’inesperienza si sente tutta. Per essere il figlio che nessuno sapeva esistesse finché Peter Gabriel non si fece scappare la notizia in un’intervista (Bertie aveva già due anni), qui la sua presenza ci viene imposta con una certa insistenza. D’altra parte, Kate Bush è sempre stata un’impresa a gestione famigliare, tanto nelle questioni economiche che nelle scelte artistiche: è ciò che le ha permesso di godere, dopo più di un braccio di ferro con la EMI, di incredibili libertà, e che oggi le permette di realizzare la sua idea pura di concerto, senza intromissioni esterne. I (pochi) difetti dello spettacolo sono cancellati dall’opportunità più unica che rara di assistere alla visione intatta di un’artista incontentabile e maniacale.
In un’intervista del ’79, Kate Bush spiegò che non amava parlare durante i concerti. Che salutare, ringraziare e presentare le canzoni rompeva l’illusione di uno spettacolo concepito come una pièce teatrale. Nel 2014, quindi, è ancora più sorprendente vederla interagire con gli spettatori e con la band (per non parlare di quando, a fine serata, incita la platea a cantare “Tanti auguri a te” al fonico Greg). Kate Bush mostra una serenità che ai tempi non le era concessa, e i media e il pubblico che oggi la riaccolgono così calorosamente rappresentano l’Inghilterra che chiede scusa per avere spinto all’esilio una delle sue voci più brillanti. Ci sono voluti tre decenni, ma la generosità di Before the Dawn ripaga l’attesa.
 In una grotta, c’è una donna che segna il numero di giorni come farebbe un carcerato – non sulle pareti ma su un librone usurato – e inizia a ballare divertita attorno a un calderone e stalagmiti. A un certo punto la sua voce prende forma e diventa una nuvola di vapore verde che l’avvolge. Sembrerebbe un video perduto di Kate Bush degli anni ’80, se non fosse che questa strega canta col linguaggio dei social. Il testo parla infatti di sexting e astinenza e lei, dopo avere rifiutato foto che “peggiorerebbero la situazione”, cede ed esclama: “show me the banana”. “So Hot You’re Hurting My Feelings” è bel un momento di stregoneria pop ed è anche l’apice di un’azzeccata campagna promozionale con cui negli ultimi mesi Caroline Polachek si è ripresentata sulle scene.
In una grotta, c’è una donna che segna il numero di giorni come farebbe un carcerato – non sulle pareti ma su un librone usurato – e inizia a ballare divertita attorno a un calderone e stalagmiti. A un certo punto la sua voce prende forma e diventa una nuvola di vapore verde che l’avvolge. Sembrerebbe un video perduto di Kate Bush degli anni ’80, se non fosse che questa strega canta col linguaggio dei social. Il testo parla infatti di sexting e astinenza e lei, dopo avere rifiutato foto che “peggiorerebbero la situazione”, cede ed esclama: “show me the banana”. “So Hot You’re Hurting My Feelings” è bel un momento di stregoneria pop ed è anche l’apice di un’azzeccata campagna promozionale con cui negli ultimi mesi Caroline Polachek si è ripresentata sulle scene.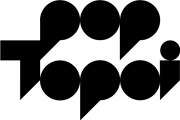


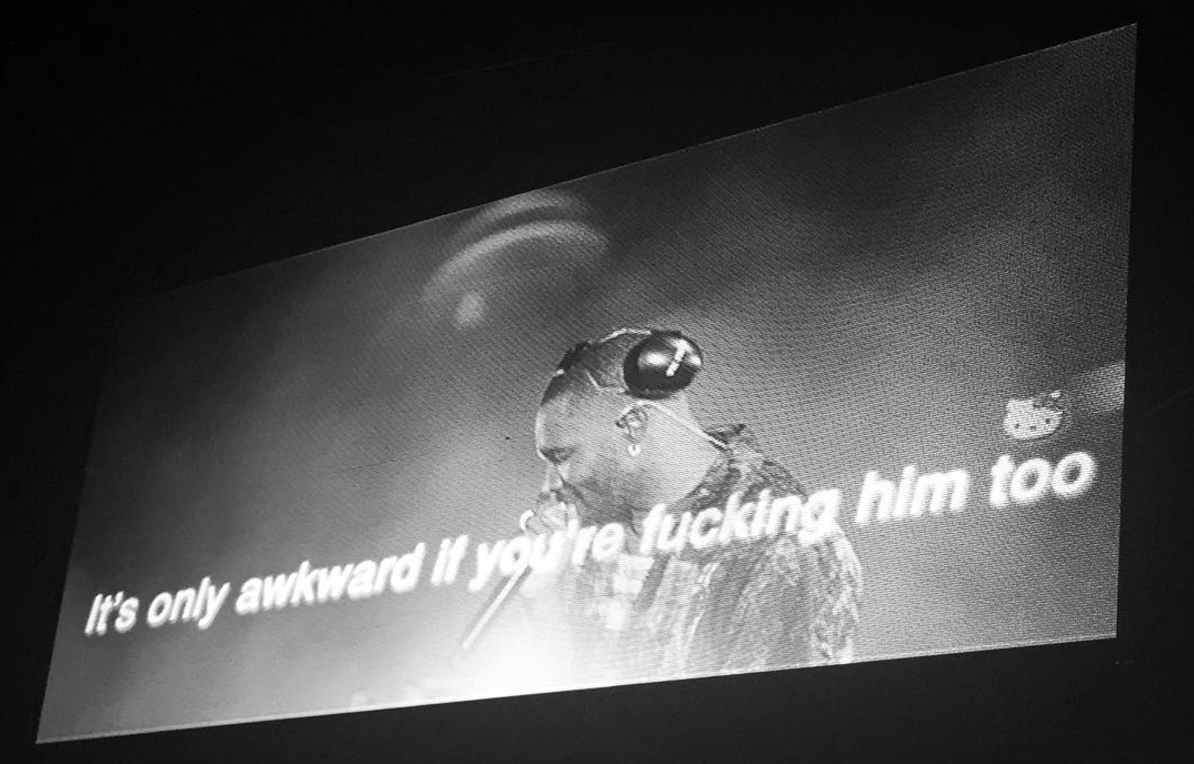


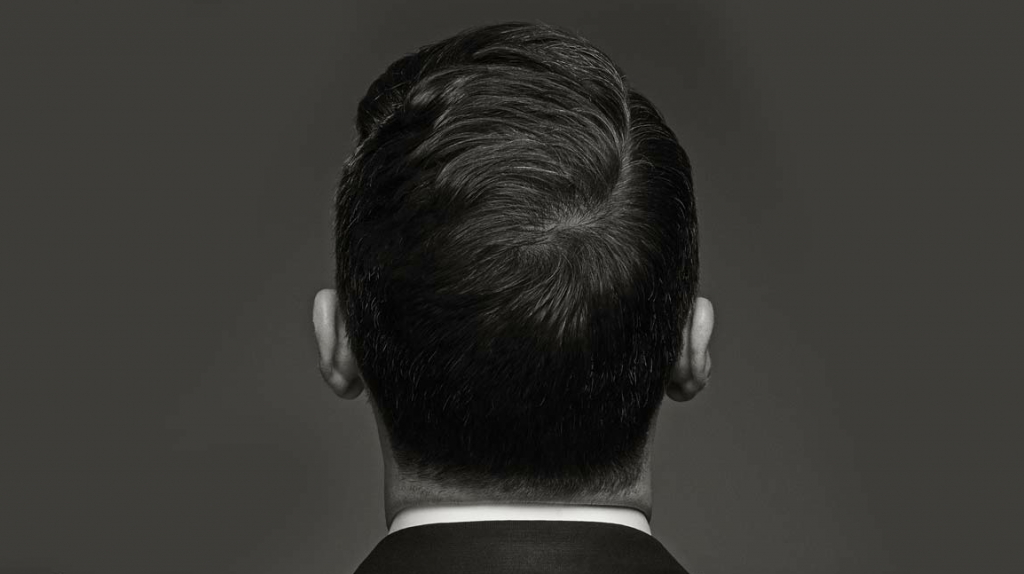


 Non inizieranno certo a ballare stasera, ma sorridono molto, perché trovarsi davanti un pubblico così affezionato e partecipe – a Londra, per giunta, dove
Non inizieranno certo a ballare stasera, ma sorridono molto, perché trovarsi davanti un pubblico così affezionato e partecipe – a Londra, per giunta, dove 

