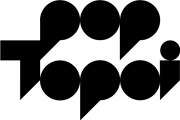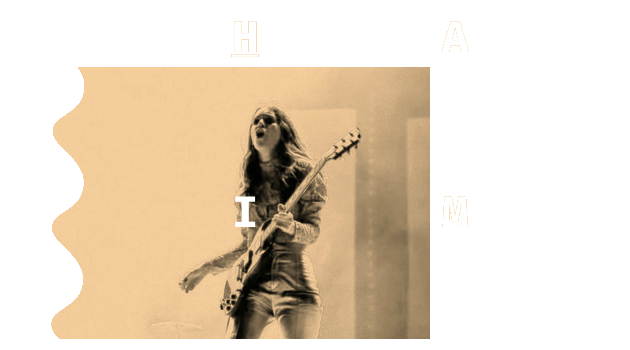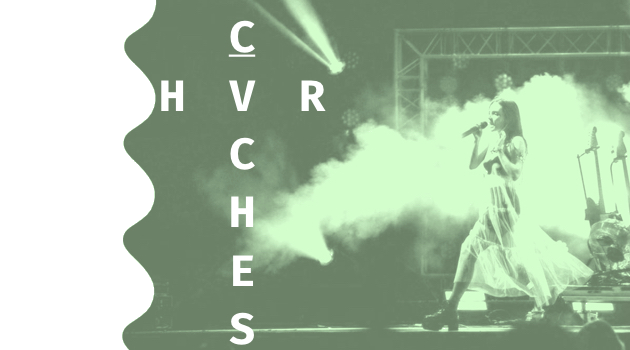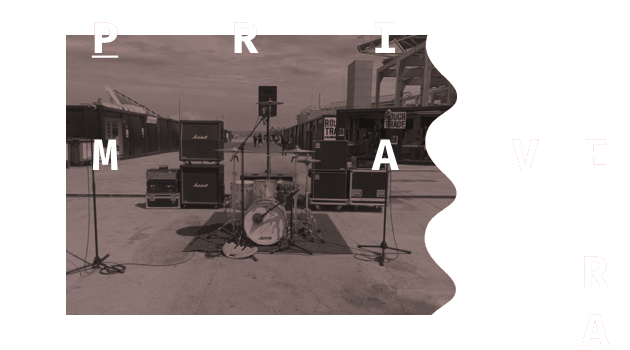
La terza e ultima giornata del mio percorso “Lilith Fair” dentro il Primavera Sound inizia col concerto-per-darsi-un-tono di questa edizione. Jane Birkin porta al main stage la sua raccolta di classici di Gainsbourg riarrangiati per orchestra sinfonica – una trovata che conferma il Primavera come una splendida eccezione nel panorama dei festival internazionali. Delle non-doti vocali di Birkin è superfluo parlare visto che ha superato i cinquant’anni di carriera, ed è vero quello che diceva lei stessa ieri in conferenza stampa: la bellezza degli arrangiamenti orchestrali di Nobuyuki Nakajima non ha quasi bisogno di una cantante. Il momento, al tramonto e davanti a un pubblico (quasi) silenzioso, è suggestivo e lei lo sottolinea: “Vedere tutta questa gente, sul mare, a Barcellona, con questi musicisti eccezionali, avrebbe commosso [Serge]”.

Se dopo la sua megahit danzereccia aveva pubblicato con un disco tetro e doloroso, col nuovo lavoro (in uscita venerdì) Lykke Li prende ancora una volta una direzione inattesa. Il male di vivere resta, ma l’influenza del chill pop delle classifiche (con addirittura una spruzzata di trap) snatura un po’ lo spirito che la rendeva così speciale. Tant’è vero che i momenti migliori del concerto di oggi restano le tracce di I Never Learn. La cantante svedese si muove inquieta e senza mai sorridere tra drappi con gigantografie dei suoi occhi malinconici che osservano il pubblico. Con titoli come “so sad so sexy” la sua dichiarazione d’intenti è chiara, ma anche “I Follow Rivers” nella versione live perde quel goccio di spensieratezza che la rese un successo. È un concerto che andrebbe visto in un luogo più silenzioso, contenuto e buio.

Lorde quest’anno ha guadagnato una nomination ai Grammy per il premio più prestigioso (Album of the Year), ma è stata l’unica in quella categoria a non avere ricevuto un invito a esibirsi alla cerimonia. Ha reagito twittando: “se non siete sicuri che sono capace di mangiarmi un palco, venite a vedermi di persona”. Il tour in questione è già alla sua terza versione: nella prima, si raccontava la storia di una festa con una teca gigante sul palco piena di ballerini; nella seconda, per i club, Lorde sperimentava con visual e installazioni luminose; nella terza, in corso, lo spettacolo è diventato essenziale. Ci sono ancora coreografie e qualche elemento video, ma le distrazioni sono poche e non servono. La cantautrice è diventata una mega-popstar che ancora non può permettersi gli stadi, ma mangia davvero ogni palco che incontra. I ballerini la fanno volare da un lato all’altro, interagisce col pubblico piazzandosi sotto l’occhio di bue per raccontare della solitudine che ha ispirato “Liability” (l’unica vera ballata in scaletta), abbraccia la folla che non la vuole più mollare. Mostra un po’ d’ingenuità solo quando dice che è contenta di suonare vicino “all’oceano” – e, a proposito di oceano, accenna “Lost” di Frank Ocean alla fine di “The Louvre”. Il gran finale con “Green Light”, in cui chiede a tutti di usare le ultime energie rimaste, è uno dei momenti più euforici ed emozionanti di un live di recente memoria, e quando ci si ricorda che la ragazza a 21 anni è già un’headliner con questo talento, viene da chiedersi di cosa sarà capace in futuro. Gli organizzatori della cerimonia dei Grammy non sanno davvero cosa si perdono.

Si va verso il Pitchfork stage per un’occhiata ad ABRA, giovane artista R&B da Atlanta che si esibisce completamente da sola sulle sue basi registrate (in tutti gli articoli su di lei troverete queste due parole: “bedroom producer“). Nei primi brani, stilosi ma poco incisivi, il contesto sembra fuori misura per una performer forse più abituata ai club. Ma ABRA supera la prova adattandosi in fretta, e il pubblico con lei, partecipando con trasporto. Io, che pensavo di avere usato le ultime energie di cui sopra per Lorde, ne trovo un po’ quando fa partire un campionamento della preistorica (2003) “Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)”. Non avrei mai pensato che questo percorso “Lilith Fair” dentro al Primavera sarebbe terminato con Lumidee e non m’impegnerò a trovarci un significato. Di certo posso dire che perdere qualche navigata band maschile non è stata una grande rinuncia, visto che il compenso è stato scoprire qualche nuova artista femminile. E che leggendo le notizie che arrivavano dall’Italia in questi giorni, c’è bisogno come non mai delle energie di spettacoli queer come quello di Fever Ray, rigeneranti come quello di Lorde e utopici come quello di Björk.
Foto Lykke Li, Lorde: Sergio Albert