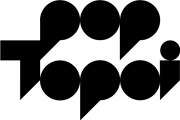Io la capisco, Lady Gaga. La capisco veramente quando, rispondendo a una domanda sulle vendite di ARTPOP durante il suo keynote al SXSW, sbotta: “What the fuck-all I have to do with Katy Perry?”. Perché è vero che lei è molto più vicina ai suoi numi tutelari David Bowie e Freddie Mercury o, per fare un nome più recente che come lei scosse e sconvolse il mainstream, Marilyn Manson. Nella sua testa, Gaga non ha nulla in comune con le tante interpreti che si limitano a dedicare mezz’ora del loro tempo per cantare su basi precotte di produttori scandinavi. E, sempre nella sua testa, Gaga sta ancora facendo del suo meglio, sta incidendo musica interessante, sta salvando ragazzini sull’orlo del suicidio, sta diffondendo l’arte ogni volta che esce di casa. Ma nella realtà, Gaga è una donna americana bianca nata a metà degli anni ’80 che fa canzoni pop come Katy Perry. Le due si scontrano nelle stesse classifiche, sono presenti sulle stesse piattaforme che conteggiano visualizzazioni e stream, ambiscono a entrare in rotazione sulle stesse radio e, quando il montatore di StudioAperto cercherà il sottofondo adatto al servizio di costume, dovrà scegliere tra “Roar” e “Applause”. E poi ci sono i fan, che fomentano gli scontri, usano numeri a caso per dimostrare la vittoria di una o dell’altra e sono convinti di avere un peso quando, invece, queste battaglie si giocano soprattutto sugli ascoltatori occasionali. Cos’ha quindi in comune Lady Gaga con Katy Perry? Per il 99% della popolazione, tutto.
Io la capisco, Lady Gaga. La capisco veramente quando, in un’esibizione di pochi giorni fa sempre ad Austin, urla: “Fuck pop music, this is artpop”. Perché è in sella a un toro meccanico che ha una tastiera all’estremità e la sta letteralmente suonando coi piedi, ed è ancora zuppa del liquido verde fosforescente che un’artista le ha vomitato addosso. Nella sua testa, è un’installazione vivente contro lo stupro. Nella realtà, ha solo servito su un piatto d’argento qualche battuta per Twitter e ha fatto incazzare Demi Lovato e le persone bulimiche.
Io la capisco, Lady Gaga. La capisco veramente quando dice che non ha voglia di suonare “Applause” al SXSW. Nella sua testa, è una canzone che non c’entra niente con uno spettacolo preparato apposta per un contesto diverso dal solito e in scaletta proprio non ci dovrebbe stare. Nella realtà, c’è una marca di patatine che ha speso due milioni e mezzo di dollari per averla e un executive che dichiara a Billboard che, per quella cifra, sperava almeno di sentire “Alejandro”.
Io la capisco, Lady Gaga. La capisco veramente quando, sempre nel keynote/intervista d’ursiana suggerisce ai giovani musicisti di non cercare “una cazzo di casa discografica” perché non ne hanno bisogno. Nella sua testa, si sta ribellando a un sistema che fa fatica a comprenderla e spera che ogni sfigato con una chitarra e una collezione di parrucche possa esprimersi in libertà senza diventare schiavo delle classifiche su iTunes. Nella realtà, qualcuno della Interscope dovrebbe dirle che il prossimo album allora potrebbe farselo da indipendente, e poi vediamo se riesce a permettersi di fare mostre al Louvre, fabbricare vestiti volanti e suonare nello spazio. Perché anche se, nella migliore delle ipotesi, Lady Gaga un giorno potesse ambire a un modello à la In Rainbows, sarebbe comunque grazie allo status raggiunto col sostegno di una casa discografica che per anni ha incoraggiato e poi tollerato le sue stranezze. Finché le stranezze hanno sotterrato la musica.