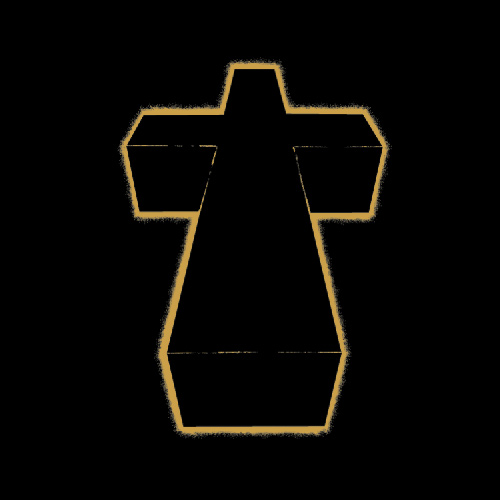 Hipster Runoff è stato per anni una sorta di tabloid dell’indiesfera. Il blog, nel seguire le gesta e le scelte di look della Alice Glass di turno o nel riservare a Wavves e Best Coast la stessa, ossessiva attenzione che le riviste patinate nutrono per Brangelina, ha aiutato a elevare una scena musicale e culturale minore. Pur con cinismo e autoreferenzialità, HRO ha adottato un approccio popolare all’indie, creando un mondo parallelo con le sue icone, le sue logiche e i suoi clichés. Questo piccolo mondo 2.0, per come è strutturato, non può però sopravvivere alla sua stessa popolarità: nel momento in cui l’indie diventa mainstream e viene accettato, fagocitato e digerito dalla cultura popolare, perde la sua ragione di esistere.
Hipster Runoff è stato per anni una sorta di tabloid dell’indiesfera. Il blog, nel seguire le gesta e le scelte di look della Alice Glass di turno o nel riservare a Wavves e Best Coast la stessa, ossessiva attenzione che le riviste patinate nutrono per Brangelina, ha aiutato a elevare una scena musicale e culturale minore. Pur con cinismo e autoreferenzialità, HRO ha adottato un approccio popolare all’indie, creando un mondo parallelo con le sue icone, le sue logiche e i suoi clichés. Questo piccolo mondo 2.0, per come è strutturato, non può però sopravvivere alla sua stessa popolarità: nel momento in cui l’indie diventa mainstream e viene accettato, fagocitato e digerito dalla cultura popolare, perde la sua ragione di esistere.
Qualche giorno fa, il blogger ha scritto un articolo che, col solito tono di serissima parodia, raccoglie diverse impressioni sullo stato attuale della scena e decreta che l’indie è morto. Come fa notare anche Inkiostro, “un certo tipo di approccio musicale esplorativo [è arrivato] al suo punto di non ritorno”: troppe band e troppa musica, ma anche troppa prevedibilità nel modo in cui i nuovi artisti vengono presentati e promossi.
I have always taken an internet-centric point of view when it comes to music, meaning that indie = internet music. An internet enabled genre that scaled alongside indie websites in order to create a day to day experience with users. Eventually, ‘mainstream’ websites began to cover ‘indie’ as well, and now it is all just a pretty standard newscycle. It has been that way for a few years, not a ‘new’ or ‘innovative take.’ But what makes the indiesphere different is that we are ‘curating/enabling/facilitating art’ so there is a direct relationship between the media and the art. It’s not like sports where the media doesn’t impact the outcome of the results [via decided on the field according 2 rules].
È un ragionamento scontato: non è mai stato così facile promuovere nuova musica, ma soprattutto scriverne. Quindi, da un lato abbiamo più musica di quanta sia possibile ascoltarne, e dall’altro abbiamo più siti di quanti sia possibile leggerne. La gara, in entrambi i casi, è estenuante e a tratti ridicola perché, nonostante l’apparente facilità, né gli mp3 né le page views generano grandi profitti.
Nel documentario Page One: Inside The New York Times, c’è un punto in cui Nick Denton di Gawker (un altro buon esempio di iper-nicchia esplosa nel mainstream) si vanta di avere fatto installare in redazione uno schermo che aggiorna continuamente la classifica degli articoli più letti sul sito. Nel frattempo, negli uffici del quotidiano più importante del mondo, i giornalisti si ostinano a usare il telefono per verificare le proprie fonti, spesso sacrificando la puntualità per la correttezza. (Che sciocchi, non sorprende affatto che siano così in crisi.) L’approccio di Gawker, con le sue linee guida per scrivere titoli cliccabili e la filosofia del “traffic whoring” (parola del loro nuovo caporedattore) è uno dei fattori che, secondo Carles di HRO, ha compromesso la scena indie e chi la curava, trasformando la blogosfera musicale in ciò che chiama content farm.
Se la SEO ha influenzato profondamente l’indie, che effetto ha avuto sul pop?
Pur riconoscendo che il pop non ha l’ossessione dell’indie per l’integrità (reale o percepita) degli artisti e non può, per definizione, temere il punto di saturazione perché il punto di saturazione è il suo obiettivo finale, i problemi sono molto simili. Si è evoluto un nuovo modo di promuovere la musica orientato sull’esposizione online che, in linea di massima, funziona come segue:
Titolo dell’album → Copertina → Tracklist → Album → Riedizione
Anteprima della canzone → Canzone → Lyric video → Teaser del video → Video
Non serve un grande intuito per capire che il nuovo sistema è fatto apposta per permettere all’artista di stare nel ciclo delle notizie il più a lungo possibile. Se fai un video e lo butti su YouTube, crei una notizia; se fornisci un’anteprima della canzone, poi la canzone, poi un lyric video, poi un teaser (o più) del video e poi (che fatica) il video, crei cinque notizie. Notizie che non sono tali e che si potrebbero tranquillamente condividere su Twitter e basta, ma che i siti musicali si trovano costretti a impacchettare con parole inutili. Colpisce soprattutto il lyric video che, nato per caso come semplice palliativo per clip in produzione, è già diventato parte integrante del nuovo modello (curiosamente, l’unica ad avere usato questo formato in maniera sensata e interessante finora è Nelly Furtado con “Spirit Indestructible”; curiosamente, è il più grande flop dell’anno). I risultati sono evidenti non solo su siti fondati e cresciuti sulla logica del traffico, ma anche su NME, Rolling Stone o Popjustice, che, pur mantenendo autorevolezza nei rispettivi settori, sono stati obbligati a trasformarsi in portali generici mangia-click.
Risolvere il problema (se vogliamo ammettere che ce ne sia uno) significherebbe scardinare le regole a cui si deve adeguare chi scrive sul web per lavoro o per passione. Quella strana logica che detta che un sito non può fare a meno di postare lo snippet di un demo in bassa qualità di un singolo che uscirà tra una settimana, o che quindici non-articoli al giorno scritti e pagati male (ma con tante tag!) generano più interesse di un profilo o una recensione scritti e pagati bene.
Forse l’indie è morto, ma il pop è una guerra tra poveri. E la stiamo combattendo a colpi di photo gallery di Rihanna.
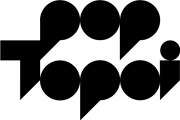
Pingback: Pop Topoi | BASTONATE